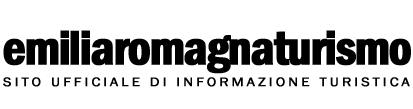Non possiamo affermarlo con certezza ma è scontato immaginare che durante il suo “ultimo soggiorno” a Ravenna Dante Alighieri avesse avuto modo di visitare le splendide basiliche della città, oggi Patrimonio Unesco, e ammirare i loro inestimabili tesori artistici.
A Ravenna era già stato in passato, presumibilmente nel 1303 e nel 1310. Aveva attraversato la pineta di Classe – “in su ‘lito di Chiassi” (Purgatorio, Canto XXVIII) – descrivendola come “la divina foresta spessa e viva”, e si era confrontato con la vita sociale della piccola località adriatica.
Nel 1318 non fu molto complicato per Guido da Polenta, padrone della città, sedurre il Sommo Poeta e indurlo a scegliere l’antica capitale bizantina come sua ultima oasi di pace e tranquillità, dopo il lungo peregrinare lontano da Firenze.
Qui avrebbe avuto modo di riunire la propria famiglia ma anche di concludere la stesura della sua “amata” Commedia.
A convincerlo certo contribuì la possibilità di avere una possibile fonte di retribuzione, grazie all’incarico di rappresentanza garantitogli da Guido Novello quale suo ambasciatore a Venezia presso il doge Giovanni Soranzo.