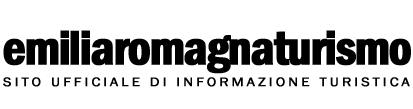Nel cuore del centro storico di Ravenna si apre in tutta la sua bellezza la BIBLIOTECA CLASSENSE, una tra le venti istituzioni librarie più grandi e importanti d’Italia.
Ospitata all’interno di un monastero camaldolese eretto a partire dal 1512, il complesso è considerato un vero e proprio gioiello architettonico e artistico tanto da richiamare ogni anno centinaia di visitatori curiosi di ammirarne gli spazi e i tesori conservati.
A partire dal primigenio complesso che hanno reso l’abbazia uno dei più grandi e maestosi monumenti dell’Ordine Camaldolese, la biblioteca – così come appare oggi – è frutto di continui cambiamenti e ampliamenti.
In particolare a segnare la sua storia fu la soppressione napoleonica dei beni monastici del 1803, quando l’antica libreria dei monaci camaldolesi fu eletta a Biblioteca Civica di Ravenna, accogliendo i fondi librari dei più importanti complessi religiosi della città.
Oggi la biblioteca è uno spazio dinamico aperto al pubblico, punto di riferimento per studenti e studiosi ma anche per appassionati di arte e cultura in generale, dotata di un patrimonio librario antico, moderno e contemporaneo tra i più importanti d’Italia.
Durante l’anno vengono infatti programmati moltissimi incontri, conferenze tematiche ma anche mostre d’arte e libraie con approfondimenti didattici e divulgativi. Uno spazio di Ravenna assolutamente da frequentare.
Gli spazi della Biblioteca Classense
All’interno delle sale e lungo i corridoi della biblioteca sono ancora visibili opere di numerosi artisti eseguite fra i secoli XVI e XVIII.
Tra gli ambienti più ammirati, vi è senz’altro l’Aula Magna o Libreria, realizzata a cavallo fra Seicento e Settecento dall’abate Pietro Canneti, ornata di statue, stucchi e scansie lignee finemente intagliate e decorata con affreschi e dipinti di Francesco Mancini.
Da non perdere sono anche i suoi chiostri monumentali, l’antica sagrestia della Chiesa di San Romualdo (ora Sala Muratori) e il grande refettorio cinquecentesco, realizzato per volontà dell’abate Pietro Bagnoli nel tardo Cinquecento, dal 1921 Sala Dantesca.
L’accesso a quest’ultima avviene attraverso un vestibolo, oltrepassando una struttura lignea sorretta a destra e sinistra da due sculture di telamoni. Ne è autore l’artista Peruzzi che nel 1581 realizzò, sempre in legno, anche gli stalli del grande refettorio.
Notevole è anche il dipinto nella parete frontale realizzato da Luca Longhi dal titolo “Le Nozze di Cana”, così come pregevole è il soffitto dipinto dagli stessi allievi di Longhi che richiamano a San Romualdo, capostipite dell’Ordine camaldolese.
In questa sala, ogni anno si tengono le maggiori conferenze dedicate al Sommo Poeta, e le cosiddette Letture Dantesche che richiamano i più illustri relatori a livello internazionale.
I tesori librari della biblioteca
La biblioteca ospita una vasta raccolta di volumi appartenenti a varie tipologie documentarie: circa 800.000 opere a stampa, antiche e moderne, manoscritti, incisioni, mappe, fotografie, documenti d’archivio e materiale multimediale.
Di grande importanza è la sezione dedicata ai Fondi Antichi che contiene volumi risalenti ai secoli XV-XVIII e circa 750 manoscritti, di cui la metà è databile tra il X e il XVI secolo.
Parte del patrimonio librario era originariamente custodito nell’antica Abbazia di Classe, dalla quale la Biblioteca prende ancora il nome. Dopo la battaglia di Ravenna del 1512, l’area attorno a Ravenna non fu ritenuta più sicura e l’ordine dei camaldolesi si trasferì all’interno delle mura cittadine portando fortunatamente con sé i suoi tesori.
Tra questi troviamo la preziosa raccolta dei testi del Canzoniere e dei Trionfi di Petrarca, che contiene anche un originale del pittore Sandro Botticelli, e l’unico manoscritto al mondo che contenga le 11 commedie di Aristofane.
Si tratta del Codice Ravennate 429, databile alla metà del X secolo, arrivato in Occidente nel 1423 grazie all’opera di Giovanni Aurispa, che salvò questo e molti altri manoscritti dall’imminente caduta di Costantinopoli, portandoli a Firenze dall’umanista Niccolò de’ Niccoli.
Infine una menzione particolare spetta alla Raccolta Dantesca, la più completa collezione di prime e rare edizioni dedicata all’opera dell’Alighieri, acquistata dal grande bibliofilo-editore fiorentino Leo S. Olschki.