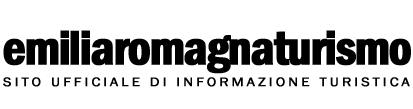Chiunque abbia voglia di vedere da vicino la vera essenza del mosaico a Ravenna non può esimersi da visitare la BASILICA DI SAN VITALE, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1996 e uno dei monumenti più importanti dell’arte paleocristiana in Italia e nel Mondo.
Siamo nel cuore della città, a due passi da alcuni dei monumenti più suggestivi del centro storico. Nei pressi si ritrovano importanti realtà come il Mausoleo di Galla Placidia, la Domus dei Tappeti di Pietra, il Museo Nazionale e molti altri.
Testimone della grandezza dell’impero bizantino, l’edificio spicca per la raffinatezza e la preziosità delle sue decorazioni e dei materiali impiegati, ma anche per l’originalità delle soluzioni spaziali adottate che trovano validi confronti con la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco a Costantinopoli.
Alle origini della basilica
Commissionata sotto il dominio dei Goti al tempo dell’arcivescovo Ecclesio (525-526 d.C.), grazie alla considerevole somma di 26 mila soldi d’oro messa a disposizione dal banchiere Giuliano Argentario, la basilica fu terminata quasi vent’anni dopo durante il regno dell’imperatore Giustiniano.
Fu consacrata dal vescovo Massimiano nel 547 d.C. e dedicata a San Vitale, un martire dei primi secoli del Cristianesimo.
Leggenda vuole che il luogo della costruzione non fosse stato scelto a caso. Sembra che qui si trovasse un sacello (V sec.) in cui erano state custodite le spoglie di Vitale.
Inoltre l’area era una zona privilegiata, immediatamente fuori dal circuito murario di età romana, ricca di domus signorili, ma anche suggestivi complessi come quello della Basilica di Santa Croce e l’annesso Mausoleo di Galla Placidia.
Una “strana” architettura
La basilica presenta un impianto planimetrico centrale e soluzioni strutturali che la distinguono nettamente dalle tipiche chiese d’impianto basilicale.
L’edificio svetta su due corpi prismatici in mattoni, uno più alto e uno più basso, a pianta ottagonale. Intorno al tamburo della cupola centrale, corre un deambulatorio (corridoio) a due piani con un settore sovrastante riservato alle donne (matroneo).
Orientata verso est, l’abside poligonale è affiancata da due sacrestie rettangolari mentre sul fronte opposto il portico d’ingresso (nartece), posto curiosamente di sbieco all’abside, mostra due esedre all’estremità che permettono di accedere alle due torri e ai settori superiori.
La decorazione interna
Appena entrati all’interno della basilica, lo sguardo viene subito catturato dalle stupende decorazioni musive dell’abside e dagli ampi volumi che l’edificio sprigiona, nonché dall’imponente volta centrale affrescata nel XVII secolo.
Risulta difficile abbracciare lo spazio con lo sguardo. La luce filtra dalle finestre creando con le decorazioni in mosaico e le superfici in marmo e pietra strani e suggestivi effetti. I capitelli a cesto riccamente decorati abbelliscono con le loro lavorazioni le sommità delle colonne.
L’interno, al di sopra dei pregiati marmi, è motivo d’estasi e sorpresa: si può ammirare, infatti, uno splendido esempio di mosaico parietale con uno sviluppo in verticale che conferisce alla basilica l’aura imperiale e rappresentativa del potere politico e religioso dell’epoca.
Se nel presbiterio i personaggi tratti da episodi dell’Antico e Nuovo Testamento ci appaiono plastici e in un contesto terreno, le figure rappresentate nell’abside (gli imperatori Teodora e Giustiniano, l’arcivescovo Massimiano) si stagliano invece ieratiche su un fondo aureo, quasi astratto, trasmettendo al fedele l’energia trascendente e metafisica della Chiesa, ma anche la forza dogmatica e politica della concezione religiosa di Giustiniano.
Da non perdere sul pavimento nell’area del presbiterio di fronte all’altare, la rappresentazione di un labirinto a forma circolare, interamente realizzato a marmo. Trovarne la via d’uscita è già un atto di rinascita.