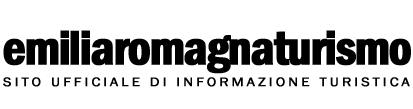Posto a lato dell’attuale Duomo di Ravenna, il BATTISTERO NEONIANO (o DEGLI ORTODOSSI) è uno dei monumenti più antichi di Ravenna, nonché parte integrante del circuito cittadino degli edifici paleocristiani dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1996.
La magia delle sue decorazioni interne, soprattutto quelle a mosaico, è tale che addirittura Carl Gustav Jung, uno dei padri della Psicanalisi, ne rimase particolarmente colpito tanto da descrivere la sua visita come una meravigliosa “allucinazione”.
Un po’ di storia
Fu probabilmente edificato attorno agli inizi del V secolo, dietro iniziativa dell’episcopato di Orso, in concomitanza con l’elevazione di Ravenna a capitale dell’Impero romano d’Occidente.
Pochi decenni dopo la sua costruzione, al tempo del vescovo Neone (450 – 475 d.C.) fu oggetto di importanti lavori di restauro che contribuirono al rifacimento della cupola ma soprattutto alla realizzazione della decorazione interna che oggi possiamo ammirare.
Tra tutti i battisteri realizzati tra il IV e V secolo nel Mondo antico Occidentale ed Orientale (Antiochia, Costantinopoli, Efeso, Treviri, Milano, Aquileia e Roma), questo edificio si caratterizza per essere il meglio conservato dal punto di vista architettonico e decorativo.
È giunto fino a noi pressoché intatto, se si esclude un ribassamento di 3 metri sotto il livello della strada dovuto al fenomeno della subsidenza che riguarda però vari edifici della città.
Il battistero, di forma ottagonale e in muratura, presenta lati alternativamente rettilinei e absidati, traforati in alto da una finestra con arco a tutto sesto e porte interrate.
L’interno, articolato in due ordini di arcate sovrapposte, mostra una ricca decorazione tripartita: marmi nella parte inferiore, stucchi nell’area mediana e mosaici in quella superiore di evidente influenza ellenistico-romana.
Così come in quella del Mausoleo di Galla Placidia, anche qui la decorazione appare straordinariamente ricca e luminosa, quasi a richiamare il passaggio dall’ombra alla luce, grazie al rito del battesimo.
La cupola in mosaico
Come di consuetudine, il programma iconografico della cupola è da leggersi in direzione ascensionale, dall’esterno verso il centro, trovando nel clipeo il suo massimo compimento.
La fascia più esterna è scandita in otto parti, in cui si alternano motivi naturali quali piante e fiori, troni vuoti che rimandano all’attesa del giorno del Giudizio Universale e altari sui quali è deposto un Vangelo.
Nella fascia mediana, su fondo blu, emergono le figure dei 12 apostoli, abbigliati di tunica e pallio, suddivisi in due schieramenti, e capeggiati da San Pietro e San Paolo. Nelle mani velate in segno di deferenza recano le corone di alloro, simbolo di trionfo, procedendo ieratici, a passo cadenzato, in una lenta rotazione.
Al centro della cupola un grande medaglione racchiude la scena del Cristo, raffigurato immerso sino alla vita nelle acque trasparenti del fiume Giordano in compagnia di San Giovanni Battista: a oggi costituisce la più antica testimonianza di una scena del battesimo del Salvatore eseguita a mosaico in un edificio monumentale.
Al centro dell’edificio, una vasca ottagonale di marmo greco e porfido, rifatta nel 1500, conserva ancora qualche frammento originale del V secolo.