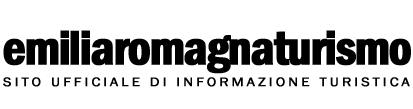Al centro della Zona del Silenzio, subito alle spalle della Tomba di Dante, sorge forse una delle più belle basiliche di Ravenna, almeno secondo molti cittadini.
Dalle forme spiccatamente romaniche, la BASILICA DI SAN FRANCESCO fu durante il periodo medievale la chiesa prediletta della famiglia dei Polentani, signori della città e ospiti di Dante Alighieri.
Probabilmente la stessa fu la più frequentata in città dal Sommo Poeta, tanto che proprio qui furono celebrati il 13 settembre 1321 i suoi solenni funerali, accogliendo temporaneamente le sue spoglie all’interno di un bellissimo sarcofago del IV secolo d.C., situato nella cappella della famiglia dei Da Polenta disposta lungo la navata di sinistra.
Storia di una basilica
La Basilica di San Francesco, dedicata in origine ai SS. Apostoli e poi a San Pietro, risale alla metà del V secolo d.C. Ben poco rimane della prima chiesa paleocristiana, soprattutto a causa dei continui rifacimenti che interessarono l’edificio nel corso dei secoli.
In particolare tra il 1261 e il 1810, e poi di nuovo tra il 1949 fino a oggi, i monaci Francescani la scelsero come loro sede con l’attuale intitolazione a San Francesco.
Il restauro del 1921 – in concomitanza con il VI Centenario della morte di Dante – infine apportò tutta una serie di modifiche che andarono a smantellare le sovrastrutture barocche presenti, riportando la basilica alla severa linearità caratteristica del Trecento, più adeguata al sentire dell’ordine Francescano.
Gli interni della chiesa
Una classica forma basilicale a tre navate, separate da due file di 12 colonne ciascuna, caratterizza l’architettura di San Francesco. A lato, all’esterno, un robusto campanile quadrato risalente al IX secolo ne arricchisce la facciata, donandole un fascino ulteriore.
Di particolare bellezza è l’abside semicircolare all’interno ed eptagonale all’esterno, che per il fenomeno della subsidenza appare oggi ribassata di 3 metri e mezzo rispetto al pavimento più recente.
Attraverso una finestra posta sotto l’altare maggiore, costituito da un sarcofago del V secolo, si scorge la cripta del X secolo, un ambiente a forma di oratorio sorretto da pilastrini destinato ad ospitare le reliquie del vescovo Neone, fondatore della chiesa. Il pavimento della cripta è costantemente sommerso dall’acqua, che tuttavia permette di ammirare i frammenti musivi del pavimento della chiesa originaria.
Lungo la navata destra, la basilica ospita anche tre belle cappelle risalenti alla metà del XVI secolo: la prima ad opera dello scultore Tullio Lombardo ospitava un tempo la statua di Guidarello Guidarelli, oggi esposta al MAR – Museo d’Arte di Ravenna; la seconda è una cappella centrale dedicata a Sant’Antonio, infine la terza è dedicata a San Rocco, con una cupola affrescata da Andrea Barbiani (1755) e una tela di Gaspare Sacchi (1517-1536).